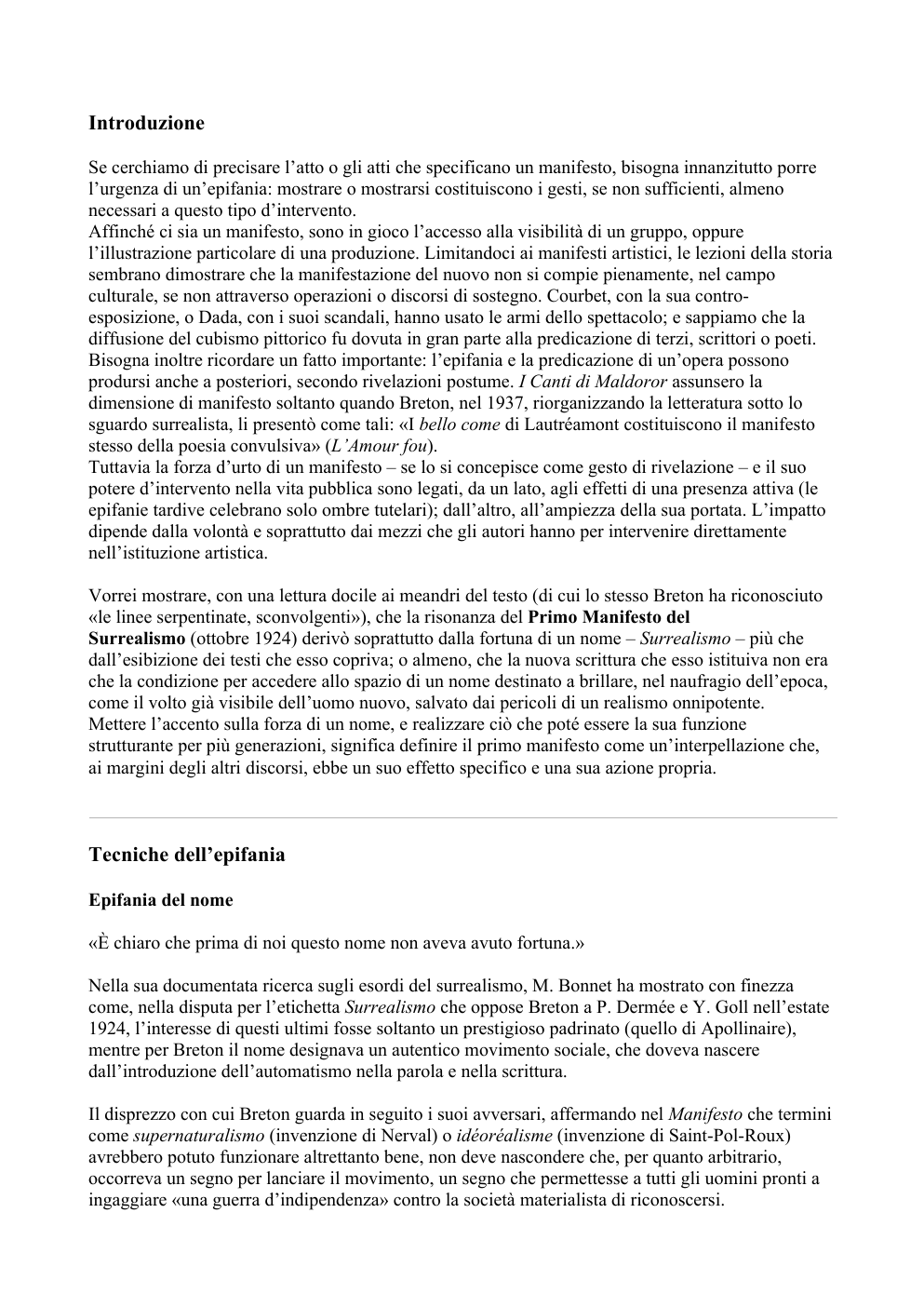Epiphanie de manifestes
Publié le 02/11/2025
Extrait du document
«
Introduzione
Se cerchiamo di precisare l’atto o gli atti che specificano un manifesto, bisogna innanzitutto porre
l’urgenza di un’epifania: mostrare o mostrarsi costituiscono i gesti, se non sufficienti, almeno
necessari a questo tipo d’intervento.
Affinché ci sia un manifesto, sono in gioco l’accesso alla visibilità di un gruppo, oppure
l’illustrazione particolare di una produzione.
Limitandoci ai manifesti artistici, le lezioni della storia
sembrano dimostrare che la manifestazione del nuovo non si compie pienamente, nel campo
culturale, se non attraverso operazioni o discorsi di sostegno.
Courbet, con la sua controesposizione, o Dada, con i suoi scandali, hanno usato le armi dello spettacolo; e sappiamo che la
diffusione del cubismo pittorico fu dovuta in gran parte alla predicazione di terzi, scrittori o poeti.
Bisogna inoltre ricordare un fatto importante: l’epifania e la predicazione di un’opera possono
prodursi anche a posteriori, secondo rivelazioni postume.
I Canti di Maldoror assunsero la
dimensione di manifesto soltanto quando Breton, nel 1937, riorganizzando la letteratura sotto lo
sguardo surrealista, li presentò come tali: «I bello come di Lautréamont costituiscono il manifesto
stesso della poesia convulsiva» (L’Amour fou).
Tuttavia la forza d’urto di un manifesto – se lo si concepisce come gesto di rivelazione – e il suo
potere d’intervento nella vita pubblica sono legati, da un lato, agli effetti di una presenza attiva (le
epifanie tardive celebrano solo ombre tutelari); dall’altro, all’ampiezza della sua portata.
L’impatto
dipende dalla volontà e soprattutto dai mezzi che gli autori hanno per intervenire direttamente
nell’istituzione artistica.
Vorrei mostrare, con una lettura docile ai meandri del testo (di cui lo stesso Breton ha riconosciuto
«le linee serpentinate, sconvolgenti»), che la risonanza del Primo Manifesto del
Surrealismo (ottobre 1924) derivò soprattutto dalla fortuna di un nome – Surrealismo – più che
dall’esibizione dei testi che esso copriva; o almeno, che la nuova scrittura che esso istituiva non era
che la condizione per accedere allo spazio di un nome destinato a brillare, nel naufragio dell’epoca,
come il volto già visibile dell’uomo nuovo, salvato dai pericoli di un realismo onnipotente.
Mettere l’accento sulla forza di un nome, e realizzare ciò che poté essere la sua funzione
strutturante per più generazioni, significa definire il primo manifesto come un’interpellazione che,
ai margini degli altri discorsi, ebbe un suo effetto specifico e una sua azione propria.
Tecniche dell’epifania
Epifania del nome
«È chiaro che prima di noi questo nome non aveva avuto fortuna.»
Nella sua documentata ricerca sugli esordi del surrealismo, M.
Bonnet ha mostrato con finezza
come, nella disputa per l’etichetta Surrealismo che oppose Breton a P.
Dermée e Y.
Goll nell’estate
1924, l’interesse di questi ultimi fosse soltanto un prestigioso padrinato (quello di Apollinaire),
mentre per Breton il nome designava un autentico movimento sociale, che doveva nascere
dall’introduzione dell’automatismo nella parola e nella scrittura.
Il disprezzo con cui Breton guarda in seguito i suoi avversari, affermando nel Manifesto che termini
come supernaturalismo (invenzione di Nerval) o idéoréalisme (invenzione di Saint-Pol-Roux)
avrebbero potuto funzionare altrettanto bene, non deve nascondere che, per quanto arbitrario,
occorreva un segno per lanciare il movimento, un segno che permettesse a tutti gli uomini pronti a
ingaggiare «una guerra d’indipendenza» contro la società materialista di riconoscersi.
Più avanti ci si interrogherà sull’efficacia di questo nome.
Basti qui ricordare che Breton stesso
riconobbe il suo desiderio di assicurarne il successo, anche a costo di spiacevoli concessioni a un
certo idealismo, «per ragioni di semplificazione e di ingrandimento volontari destinate, nel mio
spirito, a fare la fortuna di questa definizione».
Sul piano tipografico, la parola viene trattata come un lemma di dizionario: isolata in maiuscolo,
precede una doppia definizione (linguistica ed enciclopedica).
Riceve così lo statuto apparente di un
vocabolo della lingua, ufficialmente validato e registrato ante litteram.
Seguita da 24 ricorrenze ben
visibili dell’aggettivo surrealista, riceve una consacrazione ancora più forte, tanto che Breton si
presenta, nel 1924, come un nuovo Du Bellay, investito della missione di assicurare «la difesa e
illustrazione della scrittura surrealista».
Epifania del testo
«Ecco il pesce solubile che ancora un po’ mi spaventa.»
Se si considera che l’atto manifestaio principale è l’epifania di un prodotto nuovo, senza dubbio
è Pesce solubile (Poisson soluble), raccolta di poesie automatiche precedute da un lungo discorso
preliminare, a costituire il manifesto del 1924.
Esso è l’illustrazione, nel duplice senso di messa in
luce e di celebrazione, del surrealismo, di cui il resto del libro è la difesa.
Bisogna tuttavia notare che non costituisce da solo il testo esposto all’interno del testo-cornice che
funge, contemporaneamente, sia da difesa che da prefazione.
I numerosi esempi di scrittura
surrealista proposti – sotto forma di citazioni o di poesie-collage – costituiscono anch’essi una serie
di scarti nella sinuosa linearità del discorso.
La loro messa in rilievo, la loro visibilità, è assicurata
da una tecnica particolarmente efficace, fondata sul confronto di oggetti: gli enunciati “surrealisti”
rimandano agli enunciati o ai modelli citati nella prima parte del discorso, e li trasformano.
Così, nella serie degli esempi ormai classici:
— gli enunciati che iniziano con «sul ponte» o «nella foresta» trasformano le vane “immagini da
catalogo” e “cartoline” delle descrizioni tradizionali;
— «il colore delle calze di una donna…» rimanda alla povertà della “piccola osservazione” dei
romanzieri realisti;
— «la chiesa si ergeva» evoca il romanzo proustiano;
— «un po’ a sinistra scorgo» si riflette sulla lunga citazione da Dostoevskij.
Quanto ai collage, è il loro trattamento tipografico e l’uso del bianco a dar loro rilievo nella pagina.
Il breve quadro appena delineato mostra chiaramente che l’epifania da sola non basta a costituire
l’atto manifestaio.
In questo gesto sempre rischioso, un uomo o un gruppo si espone con le proprie
opere e i propri progetti: si mostra e sfida le forze di resistenza del tempo.
Ma l’esposizione alla
quale Breton si sottopone, egli la lega a una battaglia nella quale crede, e la esige anche dai suoi
alleati (membri del gruppo e lettori).
Il suo discorso può dunque essere letto come un testo di iniziazione e di intronizzazione che
comporta, per l’aspirante, una serie di prove decisive.
Solo queste ultime attestano la sua
trasformazione (occorre che, alla fine del manifesto, un enunciato come «quest’estate le rose sono
blu» sia diventato accettabile), e gli conferiscono il diritto di partecipare alla crociata e all’aura del
suo nome.
Le prove dell’adesione
«Cristoforo Colombo dovette partire con dei pazzi per scoprire l’America.»
Il proverbio che apre il discorso – «Tanto va la credenza nella vita…» – segna la bancarotta di ciò
che viene imposto come “il reale” in una società pragmatista, dove l’argomento della ragione e del
buon senso viene brandito ovunque contro la follia.
Il manifesto, scommettendo su questa follia,
riprende a suo carico, nel XX secolo, la lotta che fin dal XIX oppone il pensiero non-logico al suo
rivale “occidentale”.
Esso impegna l’avvenire e la salvezza su valori indefiniti, l’immaginazione e la surréalité; un intero
ignoto mentale intravisto come capace di restituire nuovi poteri all’uomo degradato.
Ma è proprio in
funzione di questo ignoto – posto come unico criterio di pertinenza per una ridefinizione delle
attitudini fondamentali dell’uomo – che i valori correnti vengono scossi, i segni rimaneggiati, e
l’azione avviata.
Materialismo e realismo vengono allora rivalutati e ridefiniti:
— Sul piano pratico, dalla loro “intratabile mania che consiste nel ricondurre l’ignoto al noto” e
così nel controllare bisogni e desideri.
— Sul piano letterario, dalla loro tendenza a distribuire semplice “informazione”, termine che già
allora cominciava a portare con sé la risonanza moderna della prevedibilità.
“Immaginazione” appare dunque più come un valore mobilitante che come il nome di un concetto o
di operazioni precise.
Essa drena però tutta un’attività poetica centrata sulla metafora, la cui portata
è stata messa in evidenza solo di recente dagli studi di G.
Rosolato.
Si è così portati a pensare che il manifesto di Breton sia una scommessa pascaliana, con effetti
prospettici e propulsivi, che, spinta dal violento desiderio di una realtà altra, non si arresta alle
lentezze dell’elaborazione teorica.
Nel sommovimento che produce, vacillano anche
le imago letterarie, quelle figure che strutturano l’immaginario culturale: Taine è riabilitato per le
sue interrogazioni parapsicologiche, Pascal è citato come il più sottile difensore
dell’immaginazione, e i romanzieri psicologici d’avanguardia (Barrès, Proust) sono riclassificati
come realisti.
Il lettore del 1924 è così costretto a sperimentare la mobilità del proprio terreno culturale,
l’arbitrarietà dei suoi quadri di riferimento e il disagio della propria posizione.
Le prove del labirinto
«Vorrei dargli la chiave di questo corridoio.» — «C’è un uomo tagliato in due dalla finestra.»
Il vertigine così provocato costituisce la fase preparatoria ad altri tipi di prove: l’abbandono al
sogno e l’uso della scrittura automatica, attraverso i quali il lettore deve perdere poco a poco la
propria identità,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MANIFESTES DU SURRÉALISME. André Breton (résumé)
- MANIFESTES DU SURRÉALISME André Breton (résumé)
- Manifestes du surréalisme, d'André Breton
- Manifestes du surréalisme. Essais d'André Breton (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Richard Meier : manifestes pour des « villes lumières »